Veloce quiz di Halloween: cos’hanno in comune il Pinocchio mascotte dei mondiali di ciclismo su strada Toscana 2013, Dracula e il Joker antagonista di Batman?



Terminologia, localizzazione, traduzione e altre considerazioni linguistiche

Veloce quiz di Halloween: cos’hanno in comune il Pinocchio mascotte dei mondiali di ciclismo su strada Toscana 2013, Dracula e il Joker antagonista di Batman?



Quando i significati di due parole non corrispondono.
Vietato produrre segatura?
La sentenza sul terremoto dell’Aquila (ottobre 2012) ha avuto grande rilievo anche nei media stranieri.
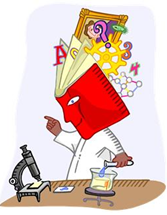 Una parola ricorrente negli articoli in inglese è scientist, che ha un significato più ampio dell’italiano scienziato, come si può verificare nei dizionari monolingui. Esempi:
Una parola ricorrente negli articoli in inglese è scientist, che ha un significato più ampio dell’italiano scienziato, come si può verificare nei dizionari monolingui. Esempi:
scienziato – studioso o promotore di una scienza o di una sua particolare disciplina, per lo più con riferimento alla posizione di particolare preminenza o prestigio acquisita [Devoto-Oli]
scientist – someone who works or is trained in science [LDOCE]
In un intervento su giovani e lavoro, il ministro Fornero ha dichiarato che i giovani “non devono essere troppo choosy, come si dice in inglese”. Ci hanno dovuto pensare i media a tradurre choosy in italiano: incontentabile, esigente, difficile, schizzinoso.
La dichiarazione lascia perplessi anche da un punto di vista lessicale, e non solo per l’ennesimo forestierismo superfluo. In inglese choosy appartiene infatti a un registro informale e quindi non mi è chiaro perché il ministro lo abbia preferito agli aggettivi disponibili in italiano. Forse ritiene che si tratti di una parola prestigiosa?
Le grammatiche della lingua italiana spiegano che nelle frasi completive introdotte dal verbo dire si usa soprattutto il modo indicativo ma si può usare il congiuntivo se il soggetto è generico e indeterminato (si dice, dicono ecc.). Le frasi “dicono che apre” e “dicono che apra” sono quindi entrambe grammaticalmente corrette.
In queste due occorrenze, però, mi pare che l’indicativo strida:
![]()
Dopo il post di ieri, devo ammettere che anch’io sono una vittima di un particolare tipo di click bait: se nelle home page di alcuni media italiani vedo le firme che associo a notiziole tradotte goffamente dall’inglese, spesso apro gli articoli per vedere che errori ci sono.
 In inglese click bait descrive un’immagine, un titolo o un link di una pagina web che attira l’attenzione dei lettori che, “adescati”, ci fanno clic sopra. Lo scopo più comune degli “acchiappaclic” è quello di generare traffico, ad es. verso pagine con pubblicità, ma possono esserci anche finalità fraudolente.
In inglese click bait descrive un’immagine, un titolo o un link di una pagina web che attira l’attenzione dei lettori che, “adescati”, ci fanno clic sopra. Lo scopo più comune degli “acchiappaclic” è quello di generare traffico, ad es. verso pagine con pubblicità, ma possono esserci anche finalità fraudolente.
Come immaginate un “ponte trampolino”?
Chi/cosa c’è sotto il letto?
infelice traduzione del verbo inglese “grill” in @la_stampa
Insolita segnaletica verticale.
Nella traduzione italiana di questa striscia dei Peanuts c’è un’incongruenza:
Il conteggio finale a cui arriva Sally non corrisponde al totale delle parole tra virgolette ma è una traduzione senza adattamento della striscia originale di Charles Schultz:
Ma secondo voi quante sono le parole? Ecco le due frasi, senza punteggiatura:
Ho la fortuna di avere poca familiarità con i medicinali, però mi incuriosiscono i loro nomi.
 Mi piacerebbe sapere, ad esempio, come mai un noto farmaco per disinfettare la gola si chiami Strepsils* nella maggior parte del mondo, incluse Francia e Spagna, ma Benagol in Italia (però la confezione è molto simile a quella originale inglese, con tanto di tipica S del logo).
Mi piacerebbe sapere, ad esempio, come mai un noto farmaco per disinfettare la gola si chiami Strepsils* nella maggior parte del mondo, incluse Francia e Spagna, ma Benagol in Italia (però la confezione è molto simile a quella originale inglese, con tanto di tipica S del logo).
Era stato proprio facendo l’associazione Benagol = Strepsils che mi ero resa conto di come il nome di un prodotto possa influenzarne la percezione: anche se più riconoscibili, i nomi descrittivi come Contramal, Viamal e Ansiolin a me risultano poco credibili e mi fanno preferire nomi più “asettici”. Era stato interessante scoprire che in alcuni paesi, ad es. gli Stati Uniti, sono vietati i nomi di farmaci che lasciano trasparire le indicazioni terapeutiche.
Un esempio efficace.
Un articolo del Corriere della Sera, Via l’inglese dagli ospedali: il Palloncino vola meglio dello Stent [non più disponibile], fa alcune riflessioni sulla terminologia medica ma purtroppo incorre in varie imprecisioni.
L’autore* auspica una semplificazione del linguaggio clinico e come causa della sua scarsa comprensibilità indica la terminologia di origine greca e latina, le sigle e l’“invasività del vocabolario angloamericano”, implicando quindi che la semplificazione sia solo una questione di nomenclatura. Mi sembra però che in questo modo faccia confusione tra linguaggio, lessico generico (parole o vocaboli) e lessico specializzato (termini medici).
In particolare, sono rimasta molto perplessa dagli esempi scelti per concludere l’articolo:
[…] i vari Booster e Follow-up sostituibili da termini equivalenti del vocabolario italiano (la vaccinazione aggiuntiva e il controllo a distanza). Certo, è anche vero che bypass è ormai intraducibile (ridicola suonerebbe una frase tipo: «Ho fatto una deviazione cardiaca»), ma il vecchio caro «palloncino» risultava al malato molto più familiare del gelido stent, che sarà sicuramente più puntuale ma è senza dubbio più arcigno e meno leggero (da pronunciare e da portare).