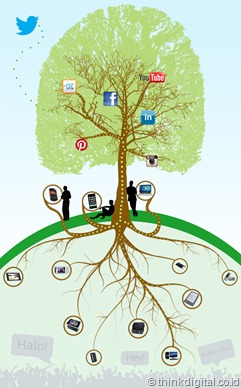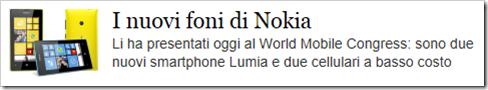It’s all in the genes: DNA and metaphor fa alcuni esempi di termini scientifici e informatici inglesi che sono entrati nel linguaggio comune in senso figurato, a volte con un significato più generico (determinologizzazione), altre invece con nuove accezioni.
Alcune delle metafore descritte hanno un equivalente in italiano, ad es. averlo nel DNA, di default e l’aggettivo dispregiativo neandertaliano.
 È invece diverso l’uso di light year, termine astronomico che identifica un’unità di misura di lunghezza ma che nell’uso metaforico inglese mantiene il significato primario della parola year e quindi serve a enfatizzare un periodo di tempo molto lungo. Esempio: The UK is light years behind Europe on renewable energy targets.
È invece diverso l’uso di light year, termine astronomico che identifica un’unità di misura di lunghezza ma che nell’uso metaforico inglese mantiene il significato primario della parola year e quindi serve a enfatizzare un periodo di tempo molto lungo. Esempio: The UK is light years behind Europe on renewable energy targets.

 competizione, quindi “competitore” ma anche “concorrente”, “rivale”, “avversario”, “contendente”.
competizione, quindi “competitore” ma anche “concorrente”, “rivale”, “avversario”, “contendente”. espressioni inizialmente non marcate e non offensive diventano inaccettabili e vengono sostituite da altre ritenute migliori.
espressioni inizialmente non marcate e non offensive diventano inaccettabili e vengono sostituite da altre ritenute migliori. 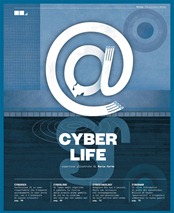 Ho sfogliato il numero di marzo 2013 di IL, il mensile del Sole 24 Ore. Tutti gli articoli e le parole chiave sulla storia di copertina, La vita indiretta. L’amore, il sesso, la fede e la guerra al tempo degli algoritmi, iniziano con cyber, ad es. in cyberlife si trova cyberreputazione, cybertruffa, cyberpunizioni e cyberbullismo.
Ho sfogliato il numero di marzo 2013 di IL, il mensile del Sole 24 Ore. Tutti gli articoli e le parole chiave sulla storia di copertina, La vita indiretta. L’amore, il sesso, la fede e la guerra al tempo degli algoritmi, iniziano con cyber, ad es. in cyberlife si trova cyberreputazione, cybertruffa, cyberpunizioni e cyberbullismo.