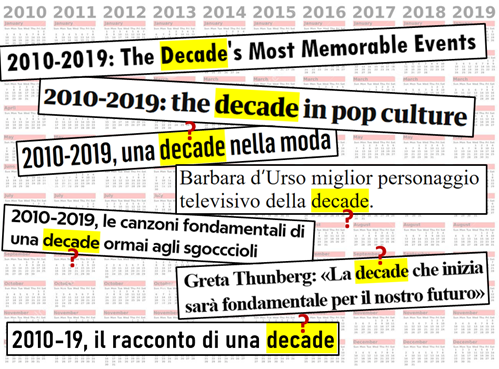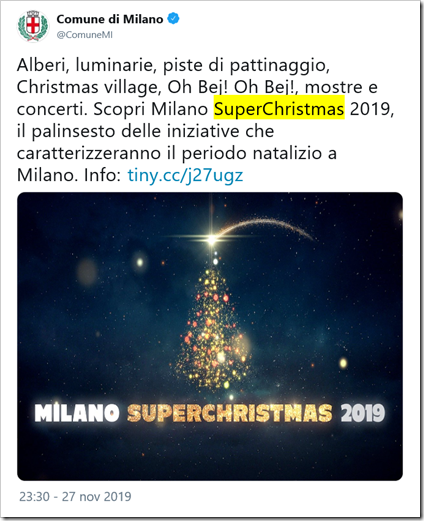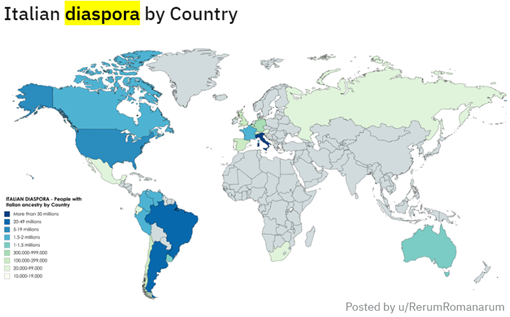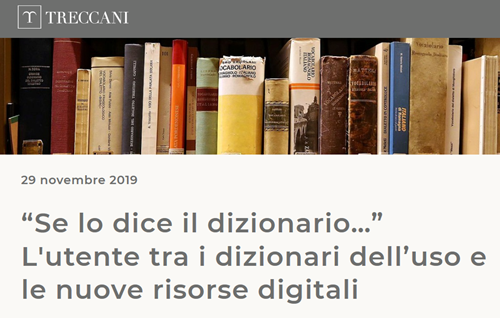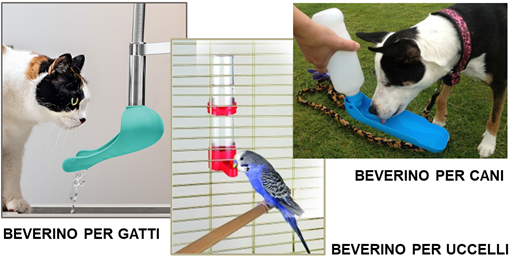Come si pronuncia l’anno nell’augurio BUON 2020?
Io dico “duemilaventi” ma in questi giorni si sente spessissimo “venti venti” e sui social imperversa l’hashtag #VentiVenti, che si ritrova anche in altre lingue, ad es. #ZwanzigZwanzig in tedesco, #VeinteVeinte in spagnolo, #VingtVingt in francese, #TwintigTwintig in neerlandese.
È un calco palese dell’inglese twenty twenty, una convenzione per leggere gli anni nelle date scomponendoli in due numeri di due cifre che è motivata da questioni di lunghezza. L’ho descritta in Olimpiadi invernali 2026: prove di lettura.